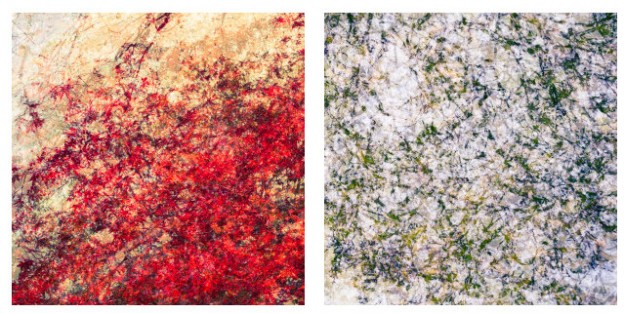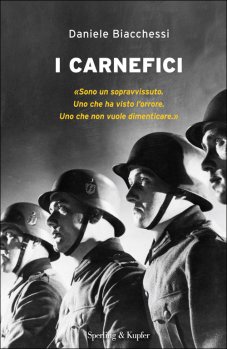Questione di prospettive: potrebbe essere questo il senso (se non forse il sottotitolo) dell’operazione intrapresa dal cantautore Luigi Mariano con questa sua seconda opera discografica intitolata “CANZONI ALL’ANGOLO” , a distanza di 7 anni dal suo disco d’esordio “Asincrono”. Diversi punti di vista sul mondo e sulle sue essenziali fenomenologie e manifestazioni tracciate in 11 brani firmati quasi tutti dall’autore. Tale percorso ci rivela un uomo in continua e costante ricerca di se stesso e della propria dimensione continuamente giocata tra il bilico della precarietà esistenziale e la necessità di trovare una consacrazione poetica nel senso letterale della propria concezione del rapporto arte –vita. Semplicità e tradizione si fondono però in maniera quasi alchemica con soluzioni forse non sempre sorprendenti ma tutt’altro che scontate soprattutto dal punto di vista dei testi, che spesso propongono un punto di partenza incuriosente per poi approdare a una “soluzione finale” di maturo realismo senza per questo arrivare al tradimento delle proprie posizioni.
L’attacco è eloquente: Luigi afferma senza mezzi termini , di avere in corpo “MILLE BOMBE ATOMICHE”: su un ritmo di medium – rock l’autore esprime, con rabbia trattenuta e desiderio di conoscenza infinita perennemente dichiarato (si ricordino le sue parole nel disco precedente “Questo tempo che ho non mi basterà , troppa sete di conoscere…”), il suo disagio di fronte all’apparente caos del mondo che però viene subito racchiuso in una domanda ossessiva che torna a mò di ritornello :“Dov’è l’errore nel tuo passato?” come ci fosse un continuo “ping – pong” fra il personale e il collettivo che è poi la dicotomia eterna dell’uomo di fronte all’universo che per spiegarselo, tende a cercarne possibili leggi chiarificatrici e ordinatrici. E infatti il Nostro arriva un giorno a “disinnescare” le proprie bombe, perché la sua “tragedia” sarebbe proprio farle esplodere per ripudiare “ciò che sei”: Quella rabbia tanto motrice quanto indispensabile si risolve in due possibili strade: quella del filosofo – uomo comune che si rende conto che “qualsiasi cosa FA BENE E FA MALE” e quella dello scienziato che quelle leggi del cosmo le cerca e passa la vita a tentare di definirle, ma da un punto di vista molto particolare: “COME ORBITE CHE CAMBIANO” è infatti una romantica descrizione dello scienziato Stephen Hawking, recentemente celebrato dal film “LA teoria del tutto” che, affetto da sla, descrive il suo punto di vista sull’universo, nel tentativo di spiegarlo nonostante la sua posizione di forzata immobilità fisica; e si direbbe che , in maniera quasi cristologica , accolli su di sé e sul suo corpo che lo intrappola, la responsabilità di quel “fuoco” universale che maledì la terra e l’umanità riempiendosi di comete che non tornano più”; ciò nonostante, l’uomo resta consapevole che un’equazione che possa spiegare la “teoria del tutto” non possa spiegare quella basilare legge universale che è l’amore.
L’anima più grottesca e ironica (a dire il vero in questo disco un po’ messa da parte e meno presente rispetto al precedente), emerge in due quadretti situazionistici :“SCAMBIO DI PERSONA” e “L’OTTIMISTA TRISTE”; il primo tratteggia su un ironico “rock blues” le sfortune di un povero avventore accusato di un crimine (poi scagionato) a causa delle sue idee di uomo, che poi finisce in politica e contro la sua aspettativa si ritrova eletto presidente; fuggendo anche da tale carica, torna a casa e trova sua moglie sul parquet sorpresa in amplesso con il commissario: una divertente metafora forse anche per celare la crisi di identità cui è costretto un uomo che cerca di essere solamente se stesso ma scopre che a stento ciò è possibile nella società mediatica che fa smarrire la propria autenticità; il secondo invece sembra riscattare la posizione descritta nel precedente: con un po’ di ottimismo , corroborato anche da “sporcature” dialettali , si può comunque trovare il riscatto della semplicità , dell’uomo senza particolari pretese cui basta poco per tornare a sorridere ad esempio una birra, gli amici al bar…
Del resto è necessario , si direbbe, trovare delle vie d’uscita ma soprattutto di risoluzione pratica se troppe cose nella vita restano irrisolte o incompiute; attraverso la metafore di un concerto di cui si fanno le prove tecniche ma poi per varie ragioni , non avrà mai inizio, “ALLA FINE DEL CHECK” si rivelano le delusioni delle più grandi aspettative della vita: scoperte che non si fanno, baci che non arrivano…ed è efficace la figura dell’artista che non può salire sul palco perché il pubblico, per varie ragioni non arriva, o perché piove o perché “non è stata fatta pubblicità”, e sono cose che chi è nel campo conosce bene, ahimè…
Il “maturo realismo” cui si accennava in apertura è dettato comunque dalla posizione insieme privilegiata e di inferiorità apparente che relega l’artista “all’angolo”, come dice il titolo dell’album e della canzone omonima. E’ da questa prospettiva , comprensiva di significati diversi e “cosmici”, che emergono le visuali variopinte e allo stesso tempo complete del Nostro: l’angolo è quello del cantautore o del poeta relegato nella nicchia, di cui spesso ci si stufa, salvo poi rendersi conto che la celebrità è forse un rimedio peggiore del male da cui si sospetta sia meglio rifuggire per mantenere la propria autenticità; è l’angolo del ring dove si sta come dei pugili suonati, da cui però si vedono meglio le cose in una visuale “a ventaglio” ; del resto Luigi si rende conto, come dice in “QUELLO CHE NON SERVE PIU’”, che “mettere tutta la vita in un secchiello” equivale a “non vivere” ; meglio mantenere un bilico scomodo che permetta di restare all’angolo e quando lo si crede , mettersi in cammino e forse non tornare più, come si dice alla fine del disco nel brano di chiusura “L’ORA DI ANDAR VIA”.
Musicalmente prevale, come si diceva, l’atmosfera rock cantautorale curata ,tra gli altri, dalla sapiente supervisione di Alberto Lombardi , già presente nel disco precedente, che arrangia anche un arricchente quartetto d’archi in un paio di brani; Si alternano dunque in maniera sapiente e dosata auree “forti” ad alcune più dolci soffuse e delicate che ben sia amalgamano, al netto di qualche soluzione strumentale di gusto un po’ discutibile (ad esempio l’introduzione di sapore un po’ “lisciaiolo” affidata al sax soprano in “Quello che non serve più”). Le presenze di “guest star” come Simone Cristicchi, Mino De Santis e Neri Marcorè sono certamente un valore aggiunto ma non riteniamo che Luigi abbia bisogno di “supporti” di sorta per rimarcare il suo valore artistico che con questa seconda prova cantautorale conferma il suo spessore. Il disco , che tra l’altro omaggia uno dei modelli di riferimento dell’artista con una cover di Bruce Springsteen “IL FANTASMA DI TOM JOAD”, consacra questo artista nel novero della tradizione cantautorale italiana secondo modelli classici che ci regalano piccoli gioielli addentrandoci nei quali troviamo perle di saggezza e di poesia che confermano una maturità artistica ormai acquisita. Quello che lascia un po’ perplessi è semmai , conoscendo alcuni modelli di formazione del nostro, la carenza di spirito dinamico e duttile in senso della “teatralità” della canzone che stavolta , rispetto al disco precedente, ha ceduto un po’ il passo a ritmi e dinamiche più intimiste privandoci così del lato più “agguerrito” e ironico che in un Luigi Mariano potrebbe fare la differenza e accattivare meglio l’ascoltatore. Un cd comunque godibile ,che si ascolta volentieri dall’inizio alla fine, sia pure con un alone interrogativo per ciò che l’opera sarebbe potuta forse risultare con un pizzico di “audacia” in più.
(L.M.)


![levanidefinitivo [Convertito].ai](http://www.lucamaciacchini.com/public/date/wp-content/uploads/2016/09/copertinalevanitoringrad-624x960.jpg)